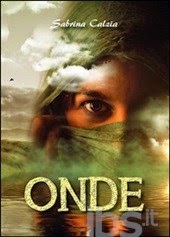Prima del trasloco aveva voluto dare un’ultima occhiata al nuovo appartamento.
Quattro piani senza ascensore non erano certo uno scherzo per le sue gambe acciaccate e la sua schiena già afflitta da troppi malanni, ma il panorama di cui avrebbe goduto ogni mattina affacciandosi lo avrebbe ripagato di ogni fatica.
Il terrazzo era molto ampio, ben assolato; e dominava l’intero centro storico, troneggiando fiero sopra i tetti sbilenchi delle vecchie case confinanti, che sembravano sistemate lì attorno apposta per sorreggerlo.
Ingombrante eredità del precedente inquilino, sul terrazzo dimorava una pianta solitaria che, con le sue efflorescenze scarlatte a forma di spiga, gli era subito parsa poco più di un’erbaccia. Alla quale peraltro, visto le sue scarse conoscenze botaniche, non avrebbe saputo dare un nome.
L’aveva guardata pensieroso, rammaricandosi per lo spazio rubato dall’enorme vaso in coccio sbrecciato che la ospitava, ormai sbiadito dal sole e dal tempo anche se un tempo doveva essere stato bello.
Almeno nella sua intenzione, si trattava certamente di uno sguardo di addio. Ma poiché era un uomo generoso, non avrebbe potuto sfrattarla da quello che era stato il suo legittimo alloggio, e si sarebbe piuttosto rassegnato ad attenderne la spontanea dipartita.
Infatti, lì dove l’aveva trovata l’aveva lasciata per mesi, senza un filo d’acqua o qualsiasi altra cura. Senza tuttavia che la sua indifferenza sembrasse destinata a raggiungere l’esito tanto atteso.
Non gli erano mai piaciute le piante, tanto meno quelle ornamentali. Così inutili eppure così vive, autonome, irriverenti. Come tutte le persone che aveva avuto accanto: così complicate, così lontane dal suo modo di essere. Persone cui era stato legato, dal sangue o dal destino, ma alle quali, per esser tanto diverse da lui, non era mai riuscito a voler bene veramente. Poiché tutti, si sa, amiamo più facilmente ciò che ci somiglia.
Più di una volta e da più parti, si era sentito rimproverare per la scarsa propensione a comunicare coi propri simili.
Ma quali simili? Lui non era simile a nessuno. Perciò, non riusciva ad amare.
Trovava più semplice affezionarsi agli oggetti che alle persone, e ne amava alcuni in particolare. Per la pazienza, la fedeltà e la comprensione che questi sapevano mostrargli. La pendola antica in salotto, la vecchia pipa del nonno, il guanciale di piume, i suoi calzini.
Amava questi oggetti perché tolleravano, senza criticarla, la sua cattiva abitudine di tardare agli appuntamenti. Vizio che, certamente, non nasceva dalla volontà di svilire il tempo altrui, ma piuttosto dal vano tentativo di ottimizzare il proprio.
Li amava perché non lo avrebbero mai deriso, per non aver mai avuto una donna, né avrebbero insinuato, in modo superficiale, fosse per via della sua perenne alitosi, figlia inconsapevole di un’infelice scelta dell’aroma del tabacco.
Infine li amava perché dimostravano, in qualche modo, di apprezzare il suo ordine. La meticolosità profusa ogni mattina nel rifare il letto, la precisione metodica nello stendere all’aria file interminabili di mutande e calzini.
Insegnava matematica al liceo, anche alla mia sezione, ed era indiscutibilmente un ottimo insegnante. Uno che masticava numeri a pranzo cena e colazione.
Era anche uno dei docenti più temuti in tutta la scuola. Sia per la materia alla quale cercava di indottrinarci, ostica a molti studenti, sia per la moralità incorruttibile, che lo portava a difendere e premiare il solo merito, dei suoi alunni. Senza cedere, come parecchi colleghi, alle lusinghe di facili privilegi; quei riconoscimenti e favori riservati, dai papà influenti di figli non proprio cervelloni, ai docenti che ritenessero di poter spianare, in nome di una discutibile bontà di intenti, il percorso scolastico un po’ traballante dei loro giovani rampolli.
A me, che ho sempre amato formule ed equazioni, il professore non faceva paura. Anzi. Nutrivo per lui un’ammirazione sincera e profonda; quasi un’infatuazione, per la sua mente: così pura, semplice, ordinata.
Il prof non sorrideva quasi mai, o almeno non lo faceva apertamente.
Perché invece io lo percepivo, il suo sorriso. Immaginandolo. Ogni volta che entrava in classe, con la cartella delle verifiche corrette infilata sotto il braccio. Ed entrando ci guardava in faccia serio, uno ad uno; per poi pronunciare, fra due labbra che sembravano quelle di un ventriloquo, una delle sue battute preferite:
“Le sufficienze si contano sulle dita di una mano monca.”
“Nel venire mi sono imbattuto in un’orda di cani famelici, attratti dall’odore di pollo spennacchiato.”
Battute che nessuno apprezzava. Tanto era schiacciato, l’umorismo, dal timore dell’ennesimo votaccio irrecuperabile da recuperare.
Nessuno tranne me. Che avrei voluto sorridergli, e solo per delicatezza non lo facevo. Perché certamente su una di quelle poche dita c’era la mia sufficienza, e un mio qualunque gesto sarebbe stato male interpretato. Ma nel mio intimo speravo, e in fondo credevo, che anche lui percepisse il mio sorriso, immaginandolo.
Nessuno tranne me. Che avrei voluto sorridergli, e solo per delicatezza non lo facevo. Perché certamente su una di quelle poche dita c’era la mia sufficienza, e un mio qualunque gesto sarebbe stato male interpretato. Ma nel mio intimo speravo, e in fondo credevo, che anche lui percepisse il mio sorriso, immaginandolo.
In silenzio apriva la cartella, impugnava a due mani il plico dei compiti, passava tra i banchi. Per consegnarci il suo verdetto, insieme a quei fogli che, il più delle volte, erano a suo dire soltanto “inutili cumuli di fregnacce”.
Dispensava ad ognuno l’occhiata più adeguata. Di disappunto o rammarico, proporzionati al grado di inutilità delle fregnacce di cui il malcapitato era riuscito a fregiarsi. Di moderata soddisfazione, nei rari casi di consenso.
Ogni volta era un trionfo, per me, la riprova di non averlo deluso. La gioia più grande che ricordi, dei tempi della scuola.
Non mi importava il voto. Ma il mio cuore idealista di ragazzina fremeva ad ogni sua approvazione, anelando come a un trofeo a una briciola della sua stima.
Aspettavo con ansia ogni verifica, e con trepidazione ancor maggiore attendevo ogni riconsegna. Perché in quegli istanti avrei sentito di nuovo le nostre menti avvicinarsi, vibrare all’unisono, sfiorarsi.
Attimi preziosi.
In cui avrei avuto, nei miei occhi, l’azzurro fugace del suo sguardo compiaciuto.
In cui avrei stretto ancora, complice il foglio conteso tra le mie e le sue mani, quel filo impalpabile che, lo sapevo, ci legava in un’amicizia segreta, bella e profonda.
Lui non aveva amici, oltre a me. Di nemici invece ne aveva tanti. Inevitabile, nella sua posizione.
E così, inevitabili, arrivarono le calunnie.
Poi, con le calunnie, le prime denunce. Spietate rappresaglie di un gruppo di ragazzotti prepotenti, che miravano soltanto a toglierlo di mezzo.
Ho sempre saputo che erano maldicenze. Perché conoscevo bene il professore, e sapevo che certe cose non le avrebbe mai fatte.
Quando la vedi vivere, una persona, puoi dire di conoscerla. Ed io lo avevo visto vivere, in casa sua.
Lo avevo osservato tutti i giorni, per mesi, dal terrazzino su cui affacciava la nostra mansarda, che per mano di mamma era un’oasi fiorita ad ogni stagione.
Per averlo a lungo osservato, ne conoscevo gesti e abitudini. E conoscendolo bene, il mio prof, ero certa della sua innocenza.
Ma il dubbio si era insinuato in molti, e in pochi continuavano a fidarsi.
Di fronte a tanti sospetti, e in preda allo sconforto, lui pensò di dover lasciare il liceo e l’insegnamento. Ché ormai era vicino alla pensione e non sarebbe più potuto, comunque, arrivarci in gloria.
Nonostante questo, i suoi ex allievi non vollero dargli tregua.
E dopo le calunnie e le denunce, arrivarono piogge di sassi sulla sua auto in sosta, e telefonate persecutorie, e minacce.
Lui tollerava tutto, in silenzio. Con una pazienza che solo io, amandolo, comprendevo.
Perché capivo che in fondo la sua vita era tutta lì, fra quelle quattro pareti spoglie della sua abitazione in centro. Che lui non aveva bisogno di altro. Che non gli servivano amicizia e comprensione, da parte di nessuno. Le mie, poi, già ce l’aveva.
Le ingiustizie e l’arroganza del mondo non potevano toccarlo. Perché del mondo lui amava soltanto la sua terrazza piena di sole dove alle cinque in punto, ogni pomeriggio, avrebbe steso un paio di mutande e un paio di calzini, mettendoli in fila a quelli dei giorni precedenti. Dalla domenica al sabato, un paio al giorno.
Li avrebbe stesi e lasciati lì, in balia del sole, del vento e della pioggia. Sette paia, sempre; poi daccapo la domenica.
Liberi di sventolare, per sette giorni. Accanto al vecchio vaso di spighe scarlatte che non volevano appassire, e anzi fiorivano sempre più rigogliose nonostante la trascuratezza.
Al liceo arrivò un supplente più giovane e disinvolto, anche nell’elargire i bei voti.
E scuola e colleghi si scordarono subito di lui, che pure gli aveva dedicato i suoi anni migliori. Dispensando amore, o almeno indulgenza, per la sua materia e per i numeri; ed insegnando a molti, non solo a me, l’importanza di giustizia onestà e stima.
Certo in cambio non ebbe nulla di buono, il mio prof.
Ma scorrettezze in risposta a rettitudine, tradimenti in replica a lealtà, spregio invece che rispetto.
Un funerale di povertà, alla fine, come unico indennizzo alle sofferenze infertegli proprio da chi, sempre, da lui aveva avuto in prestito virtù e buoni sentimenti.
E dopo, soltanto un mare di oblio.
Ma il mio ricordo è vivo, ancora oggi. Come la nostra segreta, profonda amicizia.
Vive ancora anche la sua pianta, a lungo trascurata. Che per mio tramite ha traslocato, un giorno, dalla sua terrazza al camposanto.
Perché lui potesse, dopo tanto, sentirne il profumo. E magari apprezzarne il colore, caldo e intenso. Un bel rosso cremisi, sincero come il mio affetto immutato.
Amaranto.
Che bel nome, la sua pianta; ma lui non lo sapeva.
Dal greco Amarantos... “che non appassisce”. Come l’amicizia, la stima e i sentimenti veri, che non cambiano nel tempo.
Ora è sulla sua tomba, il vecchio vaso.
Là dove l’Amaranto, generoso, potrà perdonare il mio prof.
E dove potrà vegliare, con affetto e compassione, sul suo povero corpo inerme. Concedendo alla sua anima, finalmente, protezione e benevolenza.
Quelle che, certamente, anche in vita avrebbe meritato.
Il mio cuore lo sa.
Da sempre.
.